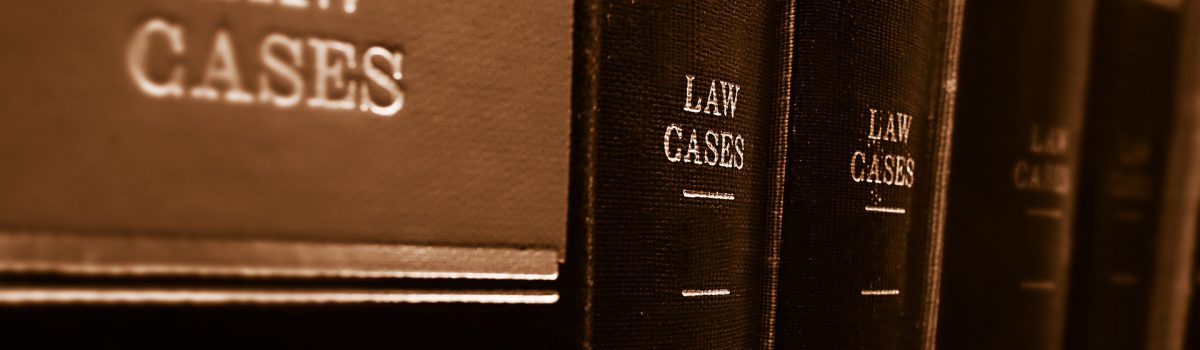- Premessa normativa e oggetto del quesito
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025 è stato indetto il referendum popolare abrogativo avente ad oggetto l’eliminazione della clausola di esclusione della responsabilità solidale del committente per i danni da infortuni derivanti dai rischi specifici propri dell’appaltatore o subappaltatore, prevista dall’art. 26, comma 4, del D.lgs. 81/2008.
Il quesito chiede agli elettori se vogliono abrogare le parole:
«Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici».
L’obiettivo, secondo i sostenitori del referendum, è quello di aumentare la protezione dei lavoratori, obbligando il committente delle opere ad una maggior presenza nella gestione della sicurezza.
- Contesto normativo di riferimento
L’art. 26 TUS disciplina gli obblighi di prevenzione nei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione, imponendo al committente:
- La verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore e dei subappaltatori.
- L’obbligo di cooperazione e coordinamento tramite il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce la responsabilità solidale del committente per i danni non indennizzati da INAIL o IPSEMA, escludendo espressamente quelli derivanti da rischi specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici.
- Effetti sistematici dell’abrogazione
In caso di approvazione del referendum:
- La responsabilità solidale del committente si estenderebbe anche ai danni causati dai rischi specifici dell’appaltatore o subappaltatore, senza limitazioni.
- Il committente sarebbe, dunque, civilmente responsabile anche per i cosiddetti “danni differenziali”, ossia quelli non integralmente coperti dall’assicurazione obbligatoria.
Questa estensione potrebbe essere interpretata anche come allargamento della posizione di garanzia in sede penale, con la conseguenza che il committente potrebbe essere chiamato a rispondere di eventi lesivi non direttamente riconducibili alla propria sfera di controllo o potere di intervento, in apparente contrasto con i principi di colpevolezza e di personalità della responsabilità sanciti dall’art. 27 della Costituzione.
- Profili di criticità
- Sproporzione tra obblighi e poteri: l’estensione della responsabilità non è accompagnata da un corrispondente aumento dei poteri di intervento del committente nelle scelte organizzative e tecniche dell’appaltatore. Tanto più che lo stesso articolo 26 citato esclude l’obbligo del committente di analisi dei rischi specifici dell’esecutore.
- Rischio di responsabilità oggettiva: l’abrogazione potrebbe configurare una responsabilità oggettiva, vietata in ambito penale. Questo perché il committente sarebbe responsabile per un fatto altrui, senza aver alcun potere di ingerenza nella gestione dei rischi specifici e propri dell’esecutore.
- Incertezza applicativa: l’assenza di parametri chiari su come il committente possa gestire o prevenire i rischi specifici altrui rischia di alimentare incertezza giuridica, demandando alla giurisprudenza il compito di definire confini e limiti della responsabilità.
- Conclusioni
L’approvazione del referendum determinerebbe:
- Un ampliamento della responsabilità civile del committente, anche per fatti connessi a rischi propri delle imprese esecutrici.
- Un possibile effetto di trascinamento sulla responsabilità penale, in assenza di chiare delimitazioni legislative.
- Una condizione di incertezza normativa e interpretativa, che il legislatore o la giurisprudenza saranno chiamati a risolvere per evitare derive incompatibili con i principi costituzionali di colpevolezza e proporzionalità della responsabilità.
- Un maggior tutela civile per il lavoratore, ma solo limitata ai danni differenziali che, in ogni caso, nella maggior parte dei casi sono coperti dalle assicurazioni private obbligatorie delle ditte esecutrici.